Racconto di Lanfranco Caminiti per il decennale di LOA Acrobax
Ora che il papà era morto, quel filo sottile che ancora li legava alla loro terra, la Calabria, rischiava di spezzarsi per sempre. Finché c’era lui, anzi finché lui era ancora in grado di stare dietro alla campagna – quei pochi ettari dove aveva qualche piede d’olivo e la vigna che era tutto il suo orgoglio –, che gli ultimi anni li aveva passati quasi sempre a letto e intontito dal dolore e dalle medicine, con una badante che lo accudiva per tutto, loro ci tornavano quando potevano, il più grande viveva a Milano, in non so quale azienda farmaceutica, la femmina a Mestre a insegnare, il più piccolo a Roma, sempre precario, ma erano secoli che non si ritrovavano insieme, i tre fratelli. Ora che si erano riuniti anche solo momentaneamente – gli ultimi giorni del padre, il funerale, le formalità di rito –, fu un pensiero comune, un riflesso immediato quello di vendere la terra, chi l’avrebbe mai seguita? E la casa. Morto lui, non c’era nient’altro.
Invece, le cose presero un’altra piega. Toccò a Giovanni, quello piccolo cui non avevano rinnovato non so quale contratto e aspettava non so quale nuova chiamata, avanzare l’idea di mettere a posto la casa, magari lui poteva farsene carico, Francesco doveva rientrare all’azienda e Maria aveva la scuola e gli studenti a aspettarla. Avrebbero spuntato un prezzo maggiore, con la casa messa a posto, o potevano dare in affitto la terra – non erano ragionamenti sensati, però erano pensieri del cuore, nodi irrisolti e ci indugiarono e se ne convinsero. Francesco trovò un modo, in realtà fu Maria che aveva sensibilità per le cose, per i soldi: disse a Giovanni di tenersi il libretto delle poste di papà, quello della pensione, e usarlo intanto che sbrigava tutta la cosa, che poteva considerarlo un anticipo di quanto avrebbero poi diviso dal ricavato della vendita della terra. E semmai fossero serviti altri soldi, lui avrebbe provveduto. «Fa così, gli disse Maria, che ti prendi pure un po’ d’aria buona. Mettici il tempo che ci vuole, hai tutta la primavera davanti». Magari, la cosa vera era che doleva a tutti quella decisione – in quella campagna avevano trascorso la loro infanzia e adolescenza, vi erano cresciuti liberi e selvaggi, e i loro ricordi erano bellissimi, strazianti per essersene dovuti andare – e Giovanni, alla fine, era il più determinato. Se fosse rimasto, l’avrebbe fatto davvero. Giovanni restò.
E si mise subito di lena buona per sbrigare la faccenda. Sparse in paese la voce che voleva vendere la terra e che gli servivano un paio di braccia per faticarci un po’ intanto a sistemare la casa. Che lo guardarono come si guarda uno che dice cose strane, ma gli dissero di prendere Zibibbo, tonto come un pollo ma forte come un mulo. «È giusto per quello che vuoi farci, tu gli spieghi, lui non si ferma più». E che gli sarebbe tornato buono pure il polacco «quello sa fare tutto, e si prende poco». Con Zibibbo e il polacco si misero d’accordo e con un furgoncino rimediato – caricarono pale, picconi, martelli, trapani, tubi, i sacchi di cemento, la sabbia, una carriola, Giovanni era stato sempre bravo con le mani – andarono in campagna il giorno dopo.
Dovevano per prima cosa sgombrare l’area, restituire al fabbricato della casa la dimensione originaria. Partirono dal pollaio, che poi era tutto assi di legno ormai marcio e reti di ferro arrugginite e travi rimediate – vide quelle vecchie traversine delle ferrovie – e pezzi di amianto per tetto. Spostavano le cose lentamente, e c’era tanta fatica, lui poi si era disabituato a lavori così duri, per fortuna Zibibbo si rivelò davvero un caterpillar e il polacco un lavoratore sapiente. Avrebbero poi buttato giù la tettoia all’ingresso con ancora il vecchio forno dove una volta si faceva il pane e poi quello che papà chiamava “il magazzino”, dove un tempo teneva gli attrezzi e i concimi e le canne per i pomodori e la pompa con il verderame, e certe annate che gli girava ci metteva pure i conigli a figliare, quattro mura tirate su alla bell’è meglio. Poi avrebbero attaccato la casa, quattro stanze, con cucina e bagno, che invece aveva un aspetto solido, mura da ottanta-novanta centimetri. L’aveva tirata su il nonno Tommaso, con le sue mani, facendosi aiutare dagli altri contadini, e dai braccianti che venivano per la vendemmia, come si usava un tempo, quando era tornato dalla guerra, la Prima, quella che i morti erano stati come le mosche e che ogni paesuzzo c’aveva il suo monumento con la lapide che non finiva mai per quanti nomi c’erano e i cannoni – pure il suo ce l’aveva, che ci giocavano da bambini.
Giovanni se lo ricordava ancora bene nonno Tommaso, un uomo dritto come un fuso, sembrava fatto di legno duro, con due baffi ingialliti dal sigaro, e le mani torte dal lavoro in campagna e gli occhi azzurri e una tosse che non lo lasciava mai perché aveva respirato il gas della guerra. Un socialista, di quelli quando a battersi per la terra se ti andava bene rimediavi il calcio dei fucili sui denti e sulla testa e se ti andava male la scarica dei medesimi fucili dei carabinieri del regio esercito. Lui non aveva paura, andava avanti, di scariche di fucili ne aveva affrontate talmente tante in guerra che doveva averci fatto un contratto perché ne usciva indenne. C’era sempre stata la sua foto nella cristalliera di casa, tra i bicchierini del rosolio che ne erano rimasti tre e le tazzine del servizio che nessuno aveva mai usato.
Partirono dal tetto, togliendo e sostituendo le tegole che si erano sbreccate, e poi smerigliarono le travi e poi tolsero via l’incannucciato dove ancora era rimasto, qualche topo che aveva tana scappò via, e poi misero le assi nuove, si stupiva di trovare ancora le cose quasi integre, l’ossatura era sana. Dopo un mese, il lavoro anche se a rilento era a buon punto – molto tempo se ne andava anche portare tutti i detriti a una discarica comunale. D’altronde nessuna telefonata gli era ancora arrivata per proporgli un qualche progetto, un qualche contratto, un qualche lavoro a nero. E il tempo era splendido, tiepido e ventilato. Si sentiva in forma, e ogni giorno che passava, invece di stancarsi, gli sembrava di diventare più forte, più resistente. Aveva ragione Maria.
Decisero di cominciare a lavorare le mura dal lato nord, quello che dava verso la vigna – un geometra l’aveva aiutato a fare uno schema delle tracce per acqua, luce e gas, la pianta del fabbricato sarebbe rimasta la stessa – e bisognava darci di trapano per togliere tutto l’intonaco che poi avrebbero rifatto, per il pavimento aveva pensato di mettere quel nuovo finto parquet fotografato che costava poco e era facile a montarsi e il linoleum in bagno e cucina.
Fu mentre lavoravano alla prima parete che saltò fuori la nicchia, l’intonaco suonava a vuoto. Un tempo si costruiva così nelle case contadine, si lasciava sempre – le mura erano profonde e solide, di pietre e mattoni pieni – una nicchia che poteva servire da mobile, come una madia, con due ante a chiuderla. Solo che nello spazio trovarono uno zaino. Era uno zaino militare, di stoffa pesante, come non ne avevano visti mai, con la trama ormai logora e consunta, e che intuirono potesse essere stato di nonno Tommaso. Dentro trovarono lettere, giornali, cartoline postali, fogli giudiziari e un diario, che Giovanni iniziò a leggere avidamente. Era il diario dei giorni del processo cui nonno Tommaso, insieme a altri commilitoni, era stato sottoposto, accusati dal Tribunale militare di avere sparato contro il tenente Miceli, lì tra le trincee del Carso. Nel carcere militare, nonno Tommaso aveva pensato di affidare a quella forma di testimonianza la sua verità, convinto probabilmente che sarebbe stato fucilato da lì a poco.
Giovanni non riusciva a staccarsi da quelle pagine: vi si raccontavano gli orrori della guerra, della trincea, delle malattie, dei pidocchi che ti succhiavano il sangue, delle agonie dei compagni rimasti avviluppati tra i reticolati della terra di nessuno, colpiti di cecchini austriaci, e che nessuno andava a prendere, del rancio schifoso, del freddo. E della follia che progressivamente s’era impadronita della mente del loro tenente, che continuava a sfiancarli di sentinelle e veglie e li mandava all’assalto come carne da macello, e di quando aveva ucciso sul posto un soldato, il primo che gli era capitato vicino, perché un plotone s’era rifiutato a un ennesimo attacco. Dovevano ricevere il cambio e andarsene da lì, invece il tenente s’era speso presso il Comando perché da lì non si muovessero – restare o morire – e loro erano già morti. Non sapeva dire chi avesse sparato – davanti a Dio l’avrebbe giurato – e non avrebbe neppure saputo dire se il colpo fosse partito dalle linee austriache, forse una scheggia di rimbalzo su qualche roccia, su qualche lastra di ferro, o se invece fosse stato uno degli italiani a sparare. No, non aveva pianto per il tenente, ma ormai non si piangeva più per niente e nessuno, si era come morti, come avrebbero potuto piangere? Diserzione, era questa l’accusa, un morbo che prese i soldati intorno Caporetto – quando i generali mostravano la loro incapacità e la loro cialtroneria – e i carabinieri passavano giornate a fucilare quelli che acchiappavano, senza neppure processo. Diserzione era il grido che i socialisti austriaci e italiani avevano lanciato contro l’insensata guerra. Nonno Tommaso s’era salvato, e anche i suoi compagni. Evidentemente, persino il Tribunale militare, o fu proprio quel giudice, non se la sentì di passarli per le armi, e era meglio evitare che la cosa si trascinasse e per l’onore dell’esercito e per la tenuta dello spirito dei soldati. Al tenente avrebbero dato una medaglia alla memoria.
Giovanni si chiese perché mai nonno Tommaso avesse deciso di seppellire quella vicenda, di celarla nell’anfratto delle mura, nessuno in famiglia aveva mai sentito di quella storia. Il diario arrivava fino al giorno della sentenza e alla liberazione. Poi, nell’ultima pagina c’era scritto così: «Ho mentito davanti a Dio».
Decise di rimettere lo zaino al suo posto, avrebbero rifatto l’intonaco bene, e non ne avrebbe parlato neppure ai suoi fratelli. Zibibbo e il polacco non ci avevano capito nulla, e andava bene così. Sarebbe stato il suo segreto con nonno Tommaso. Il segreto di quella casa.
Stava proprio cominciando ad affezionarsi a quello scatafascio.
Nicotera, 28 novembre 2012


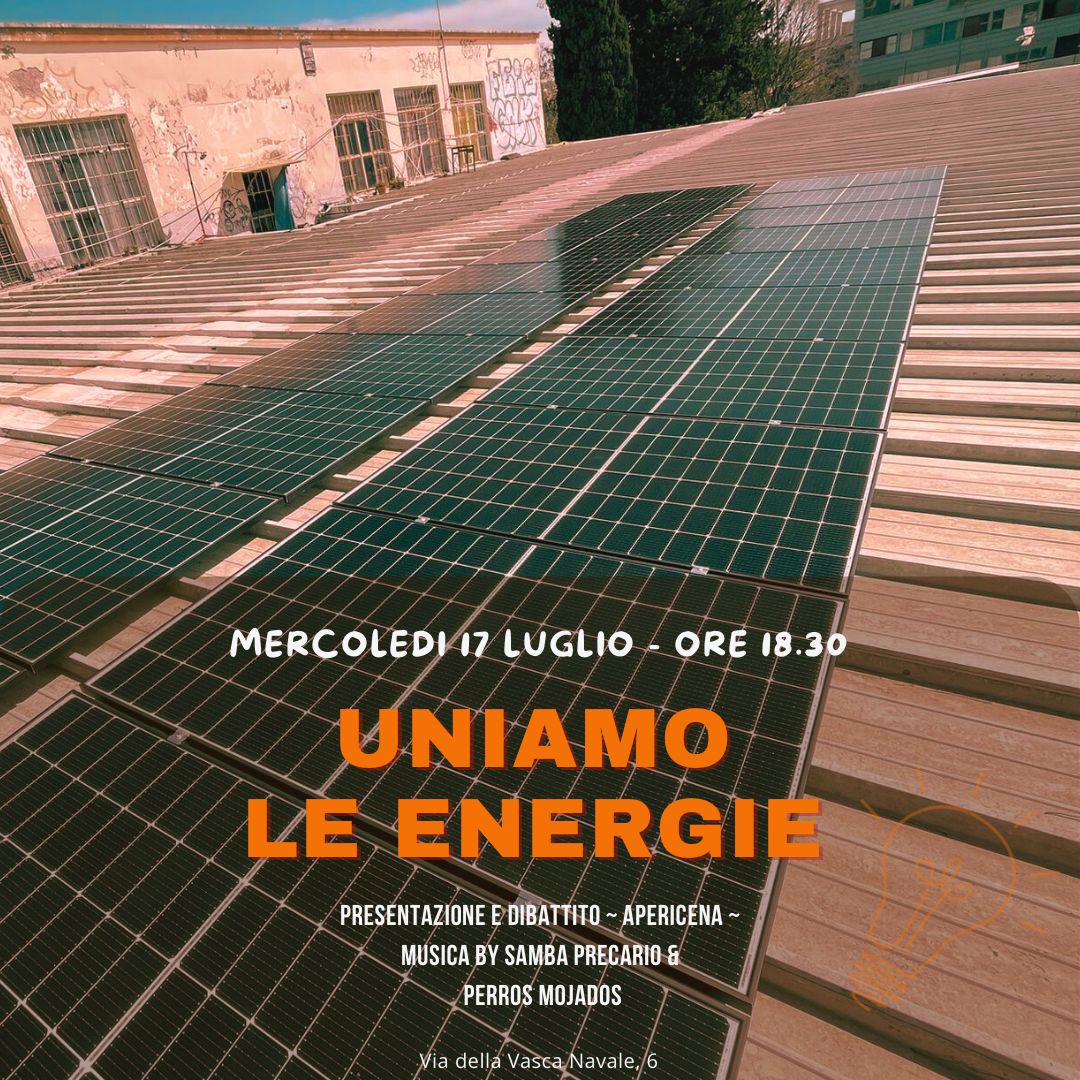
![Sabato 1 Giugno/ Cromedrop Dancef[lo]or Palestine](https://acrobax.org/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-23-at-13.48.07.jpeg)

















